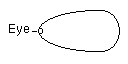1.
Ho in analisi un uomo, M., ossessionato dal pensiero di una donna, Flora, con cui ebbe una relazione di pochi mesi due anni prima. La loro passione fu travolgente, M. le propose di farle un figlio, e lei accettò. In effetti, uno dei suoi crucci è che alla sua età non è padre e non ha una compagna fissa, scivola sempre da un amore all’altro. Ma poi Flora se ne andò. Da allora lui si dispera.
Quando gli chiedo quali immagini di Flora lo assillino, mi dice che «la vede» mentre «lei mi osserva con uno sguardo incuriosito, dolce, attento… eterea.» Questo sguardo di Flora lo perseguita. E lo mette in relazione con lo sguardo in un film che lo colpì, Alien di Ridley Scott. È il volto dell’attrice protagonista, Sigourney Weaver, mentre guarda nella cinepresa, ovvero guarda lo spettatore. Ho guardato il fotogramma di questa scena, e ho trovato questo sguardo incuriosito, ma anche sull’orlo dello spavento, come in un interstizio tra fascinazione e terrore. M. mi dice anche che questo sguardo assomiglia a quello di certi bambini quando ti guardano fissi e non sanno bene cosa pensare di te, uno sguardo perplesso e interrogativo. «Uno sguardo autentico», dice, in quanto il bambino, come Flora nel suo ricordo, non maschera la propria incertezza su di te.
Nel fotogramma del film, la protagonista cerca di vedere un alieno. Degli astronauti, tra cui la protagonista, lo hanno imbarcato nella loro astronave senza saperlo, ma l’alieno è una “cosa” invisibile, senza forma né località. Sigourney cerca in qualche modo di scorgerlo… Ma l’alieno è piuttosto un principio germinale diffuso che di volta in volta si mostra in epifanie diverse nei corpi stessi degli umani, da cui fuoriescono arti mostruosi che dall’interno uccidono gli umani. Mostruoso diventa l’umano, non l’alieno, il quale non è captato come ‘sostantivo’ da nessuno sguardo. Se ne vedono solo le tracce. Weaver sta guardando quindi una cosa il cui orrore consiste in gran parte proprio nel suo non poter essere vista.
La mia impressione è che oggetto dello sguardo di Flora sia M. stesso in quanto alieno. Ma un alieno che non ha immagine, come un buco nel tessuto dello spazio e del tempo. E in effetti M. evoca lo sguardo della Medusa, che pietrifica gli umani. Dirò poi perché il mio analizzante in qualche modo è “alieno” per l’altro.
2.
Lo sguardo ha un posto di rilievo in un sogno famoso che dà nome a un paziente di Freud, l’Uomo dei Lupi[1]. L’analizzante, un uomo adulto, Sergej, racconta a Freud di un incubo che ebbe a cinque anni: sognò che lui era nel suo lettino e, d’un colpo, davanti a sé si apriva una finestra oltre cui si vedeva un albero con vari rami. Su questi rami cinque o più lupi, appollaiati immobili, lo guardavano fisso. Terrore. Dovuto non tanto ai lupi, quanto allo sguardo dei lupi, come se l’oggetto interessante non fossero loro ma lui stesso, il sognatore. Cosa può voler mostrare un sogno del genere?
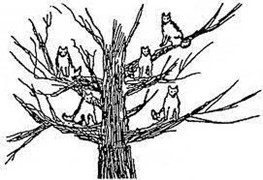
Schizzo del sogno dell’Uomo dei Lupi
Non ripercorreremo qui l’analisi di Freud, ovvero la rete di rimandi e corrispondenze da cui conclude che in quel sogno il bambino evocava il suo aver sorpreso i genitori, anni prima, intenti a un coito pomeridiano. Malgrado la sua ingegnosità, l’interpretazione è poco convincente. In verità, ciò che sembra terrorizzare il soggetto non è una scena vista, ma lo sguardo su una scena ignota, il quale sguardo diventa scena esso stesso. La lettura del sogno e lo schizzo che lo descrive sortiscono su di noi un effetto unheimlich, perturbante[2]. Lo sguardo, non ciò che è guardato, ci agghiaccia.
La produzione di questo effetto è stata tentata anche in arte e letteratura. Per esempio nell’Annunciazione di Antonello da Messina[3], dove vediamo la Madonna sorpresa, ma non vediamo l’Arcangelo la cui apparizione la turba. Certamente uno dei quadri più famosi al mondo è L’urlo di Edvard Munch[4]: una figura dal sesso indefinito su un ponte urla guardando verso lo spettatore, ma non sappiamo che cosa la faccia urlare. Come se non il volto stravolto di chi urla fosse l’oggetto orrendo, ma lo spettatore stesso. Il buco ovale centrale della bocca che urla rimanda alla pupilla – un buco – di ciascun spettatore.
3.
In un mondo pieno di specchi e di video come il nostro, diamo per scontata la conoscenza del nostro volto attraverso specchi o video. Gli Antichi, che non avevano specchi, o specchi ancora confusi e opachi, non vedevano mai chiaramente sé stessi[5] – solo per attimi, specchiandosi nelle acque chete come Narciso, o “vedendosi” nell’altrui pupilla. Il termine ‘pupilla’ rimanda allo specchio. Pupilla in greco si diceva koré, ragazza. Ma anche pupilla viene da puella, ragazza. Ora, si è mostrato che in molte lingue tra loro molto lontane la pupilla come organo viene chiamata con un termine simile a quello di “ragazza” o “ragazzo”[6]. Il successo di questa catacresi è dovuto al fatto che chi guarda nella pupilla dell’altro vede la propria stessa immagine in piccolo. La pupilla altrui, come lo stagno per Narciso, è il primo specchio usato dagli esseri umani.
Ovvero, il nostro volto, la parte più “soggettiva” del nostro corpo, è altrove da noi, è visto nel volto dell’altro. Da qui l’importanza che Lacan diede alla fase dello specchio[7]: amare noi stessi, capire noi stessi, conoscere noi stessi…. sono tutte alienazioni speculari. Se diciamo “io amo me stesso”, “me stesso” si separa da “io”, diventa il suo oggetto, il suo sembiante. Ma proprio per questo qualcosa di noi ci delude: “me stesso” non sono io, l’immagine della cosa non è la cosa stessa. Quindi, che cosa è veramente il nostro essere?
Il successo culturale della psicoanalisi da un secolo è connesso al fatto che essa ci invita a dis-identificarci dalla nostra immagine, ci fa presente che c’è una distanza tra noi stessi e le nostre proiezioni su quegli schermi della nostra soggettività che sono gli altri (intendo lo schermo su cui si proietta un film). La psicoanalisi ci promette di cogliere qualcosa del nostro essere al di là delle parvenze narcisistiche. Ma è possibile questo?
Una parte della fenomenologia filosofica giunge alla conclusione che la soggettività non ha niente a che vedere con l’interiorità, ovvero, che il soggetto è propriamente nulla. Il soggetto non è un contenitore psicologico. È la posizione popolarizzata da Sartre[8]: l’”io” husserliano è ancora cosa del mondo, la vera soggettività è la coscienza, la quale non è del-mondo, è una cavità, un non-ente. Insomma, non ci possiamo socraticamente conoscere, possiamo solo decidere e agire. In questo modo la fenomenologia tende a snobbare la psicoanalisi: non c’è inconscio, c’è solo l’atto di coscienza, oltre il quale tutto è alienazione o malafede.
Eppure, che cosa guardano i lupi immoti del sogno di Sergej? Guardano non il soggetto ma ciò che di sé al soggetto sfugge. E come nominare, dar forma, dare immagine a quella cosa di me che non posso vedere perché è in me, è me, è quel buco nel mio mondo che io sono per me? Il mio volto – e quindi il mio guardare, il mio pensare – è la sola cosa che non vedrò mai nel mondo, è una macchia nel mondo come il punto cieco della retina, la parte a me invisibile del mondo[9]. E sento che questa parte invisibile è mostruosa perché si mostra solo all’altro, anche quando l’altro mi guarda con dolcezza o amore. Io sono mostruoso perché non mi mostro mai a me stesso.
4.
La fantascienza ha sempre cercato di farci vedere ciò che a noi non si mostra, gli alieni. Di solito questi ci deludono perché vengono rappresentati in forme puerili, zoomorfe o antropomorfe, come uomini brutti, ranocchietti come ET del film di Spielberg. Non sono veramente mostruosi perché hanno un’aria umana o animale, anzi, diventano anche simpaticissimi. Alien di Scott è invece un racconto che ci offre un’idea meno scontata degli alieni proprio perché in quell’alieno non è riconoscibile una fattezza animale precisa. L’alieno che davvero ci turba non è zoologia immaginaria.
Le figure dell’alieno diventano meno ridicole quando esse vengono rappresentate come un’istanza di illusione: così in Solaris (1961)[10] di Stanislaw Lem, e soprattutto nella trilogia dei film Matrix dei fratelli Wachowski – qui l’alieno è una macchina invisibile, che sfrutta l’energia umana facendo vivere gli umani in una realtà illusoria. L’alienità in questi casi consiste nel dare realtà al non-reale, nel cambiare i posti tra realtà e immagini. Torna insomma il vecchio tema platonico della realtà empirica come simulazione (mimesis).
In The Invasion of Body-Snatchers[11] gli alieni prendono il posto degli umani assumendo le fattezze di ciascun essere umano, solo che, a differenza dell’umano a cui si sono sostituiti… non desiderano. Quindi, non soffrono e non godono. Gli alieni realizzano qui un certo ideale filosofico antico di atarassia. Ma spinozianamente sono non-umani.
Nella letteratura e cinema moderni, abbiamo detto, l’alienità tende a essere una perfetta simulazione di realtà. Essa anticipa il trionfo della simulazione di attività mentali umane attraverso robot. I progressi dell’IA ripropongono il problema essenziale: se le attività di pensiero umane anche più elevate possono essere perfettamente simulate da macchine digitali, allora che cosa è umano essenzialmente? Se le macchine riescono a dimostrare teoremi, che cosa resta di veramente umano della mente? A differenza di quel che scriveva Platone, la sapienza cessa di essere la virtù primaria dell’anima (dato che le AI sono sapienti). Allora, se la ratio è facilmente meccanizzabile oggi, che cosa ci rende umani oltre la ratio?[12] È una questione che lasciamo qui aperta.
La rappresentazione dell’alienità nel romanzo di Josh Malerman Bird Box, portato poi sullo schermo[13], rinnova il mito dello sguardo della Medusa. Qui l’alieno è completamente invisibile a noi spettatori, e per fortuna, perché gli esseri umani che vedono questo “qualcosa” hanno un impellente desiderio, che soddisfano all’istante, di suicidarsi. I pochi sopravvissuti devono vivere in case con le finestre appannate, perché i mostri si fanno vedere solo all’aperto, alla luce del sole. Quando gli umani devono uscire di casa, devono bendarsi completamente gli occhi, la cecità li salva. Noi spettatori ne percepiamo la presenza vedendo solo un leggero svolazzare di foglie, avvertiamo un alito… Vedere l’Altro implica il bisogno impellente di non vedere più nulla, morire. Si mostra qui una sorta di rovesciamento ironico del mito platonico della caverna: vedere il mondo in piena luce è mortifero, mentre il ritiro nella caverna (in casa) salva.
Il punto è che la testa della Medusa del mito antico è rappresentata, anche se, notiamo, solo come testa tagliata, quando cioè non c’è più Medusa. Perciò, quando vediamo il Perseo di Cellini a Firenze, non ci pietrifichiamo. Insomma, il vero mostro si vede solo non nella morte, ma nell’attimo che segna la morte. E se il mostro che ci fa morire fosse proprio la morte stessa, il rovescio dell’io che fa buco nel campo del vedere-dire? Qualcuno potrebbe dire, in modo blasfemo, che il mostro che non si vede mai se non morendo è Dio. Anche nella Bibbia è difficile vedere Dio. Mosè lo vede? O ne sente solo le parole? Quando Dio scende dal monte per manifestarsi al popolo d’Israele, si mostra solo come nube, fuoco, fumo, suono assordante di corno… Ovvero Dio si mostra solo in modalità catastrofiche, come estremo disordine naturale, come confusione esplosiva di figure e di suoni.
5.
Torniamo a M. Se la mia ipotesi è corretta, perché egli si identifica a quell’alieno che Flora guarda ad un tempo con interesse e timore?
In effetti, egli non parla mai veramente col cuore: ha un linguaggio forbito, cauto, diplomatico, medita ogni parola. Di mestiere fa l’attore, quindi è abituato a presentarsi come qualcuno che lui non è. Egli è venuto via presto dalla sua famiglia rurale per viaggiare ed essere libero, ma è come se qualcosa di lui essenziale fosse rimasto a casa dalla mamma. Questa mamma è la persona che adora di più al mondo. Ha avuto storie con varie donne, con una ha cercato di fare un figlio… ma alla fine ci ha rinunciato. Lamenta il suo essere single, ma di fatto si mette con donne, come Flora, che lui descrive come sguscianti, inafferrabili, “eteree”… Ma è lui, anche, sgusciante, inafferrabile, etereo. C’è un suo non-esserci che egli prende come disposizione a essere abbandonato. Ma di fatto egli esiste pienamente solo quando soffre per Flora, quando è ossessionato dalla nostalgia dello sguardo di lei, per il quale resta alieno. È alieno a sé stesso, nel senso che non riesce a vedere qualcosa che gli sfugge… quel buco che lui stesso è.
Freud credette di dare un’immagine precisa al mostruoso, dicendo che l’Uomo dei Lupi guardava originariamente il coito dei genitori. Ma questa Urszene, scena originaria, è una metafora, ovvero un’immagine che vela “la scena”, quella vera. Certo, per un bambino il coito è un atto impensabile, in quanto non sa dargli un nome, un senso. Non è qualcosa di osceno (da ob-scenus: scena di malaugurio) da vedere, è qualcosa che non si può vedere perché non ci sono i significanti per dirlo. Credo che l’Uomo dei Lupi esprima l’orrore non di vedere quel che non dovrebbe mostrarsi, ma di non vedere qualcosa che pur si mostra. Un mostrarsi non visivo, un mostrarsi che non si può dire e quindi non si può vedere alla luce del sole. È come un nodo opaco della soggettività, che non si limita al nostro sentirci, alla nostra sensazione di essere vivi, ma come un grumo di essere che nessuna narrazione riuscirà a sciogliere, e a cui in fondo ci riferiamo sempre quando nel discorso vogliamo esprimerci. Questo fondo opaco di ogni soggettività, che la mitologia moderna descrive come un qualcosa di informe e vischioso, è ciò che vogliamo cogliere al fondo dell’umano. Direi, l’opacità del nostro esistere, matrice però di ogni rappresentazione simbolica del mondo, di ogni trasparenza delle cose nel linguaggio.
Ora, come abbiamo detto, il mio volto è ciò che continuamente mostro ma non vedo. Il mio volto che guarda è come la luce per gli Antichi, qualcosa che mi permette di vedere le cose ma che in quanto tale non può essere vista (anche se vedo, accecandomi, la sua sorgente principale, il sole). Come a ogni cosa vista devo presupporre la luce, a ogni cosa che dico e vedo devo supporre qualcosa di invisibile che chiamiamo soggettività. Questo mostro.
6.
L’estraneità dello sguardo a ciò che guarda è stata evocata in filosofia per illustrare il rapporto contemplativo (non attivo) del soggetto al proprio mondo. In particolare Wittgenstein, nel Tractatus (5.6331) ci propone un’immagine:
5.632 Il soggetto non appartiene al mondo ma è un limite del mondo.
5.633 Dove, nel mondo, un soggetto metafisico andrebbe visto? Tu dici che questo caso è proprio come quello dell’occhio e del campo visivo. Ma tu non vedi realmente l’occhio.
E nulla nel campo visivo fa concludere che esso sia visto da un occhio.
5.6331 Perché il campo visivo non ha una forma come questa:
5.634 Ciò inerisce al fatto che nessuna parte della nostra esperienza è anche a priori.
[……..]
5.641 Vi è dunque davvero un senso in cui nella filosofia si può parlare dell’Io in modo non psicologico.
L’Io entra nella filosofia con questo: che «il mondo è il mio mondo».
L’Io filosofico non è l’uomo, non è il corpo umano o l’anima umana di cui tratta la psicologia, bensì il soggetto metafisico, non una parte del mondo, ma il suo limite.
Da notare che qui Wittgenstein descrive il campo visivo come una goccia[14], e non come un circolo, dato che il nostro campo visivo di solito è concepito come una sfera di cui siamo il centro. Appunto, l’Io metafisico non è affatto il centro del campo, insomma non sta da nessuna parte di nessun campo[15], e difatti il grafico illustra non le cose come stanno, ma come le cose non stanno.
Evidentemente in Wittgenstein quella dell’occhio e del campo visivo è una metafora di qualcosa di più ampio, che è il dicibile. Dato che tutto il visibile è anche dicibile. Nel posto dell’occhio possiamo mettere il soggetto dicente. In questo modo Wittgenstein vuol dirci che il soggetto dicente – che chiama qui Io metafisico – non è parte del dicibile, è ineffabile. Usando una sua distinzione fondamentale[16] – quella tra mostrare e dire – possiamo dire che il soggetto dicente si mostra in ciò che dice, così come l’occhio in qualche modo si mostra in ciò che vede, ma non può essere detto né visto. Eppure, dicendo che questo dicente si mostra solo, non ne dice pur sempre qualcosa? E quale è lo statuto di questo dire del soggetto dicente di cui nulla si può dire? Di esso possiamo dire «è ciò che non è e non è ciò che è»[17].
Se l’io che Wittgenstein chiama metafisico è il limite del mondo, esso ha la stessa posizione della morte. Anche la morte è il limite della vita, e proprio in quanto tale è qualcosa che è e non è. Capiamo benissimo che cosa significhi non essere vivo, dato che prima della nostra nascita non c’eravamo e la cosa non ci disturba affatto. Quel che ci disturba, e che ci pare orrendo, è quel “mostro” della nostra morte come limite del nostro vivere. È come l’attimo, sempre già passato e sempre ancora da venire nel momento in cui cerchiamo di renderlo presente. La morte è il lato opposto dell’Io metafisico, ed entrambi ci imbarazzano, ragion per cui tanta filosofia cerca di negare sia l’una che l’altro. La metafisica ha la passione di superare, cioè di rimuovere, sia la soggettività che la morte.
Il punto è: evidentemente l’occhio non è parte del proprio campo, ma cosa accade quando incontriamo nel nostro campo un altro occhio? Possiamo dire che l’occhio dell’altro è semplicemente oggetto tra gli oggetti nel mio campo? No. L’occhio dell’altro è un buco nel mio campo visivo, e sappiamo che può inghiottirmi, per esempio nello sguardo dell’altro che mi soggioga o mi umilia. Del resto l’occhio a sua volta incornicia il buco della pupilla. Attraverso la pupilla non vediamo il vuoto ma… un abisso. L’occhio dell’altro non rappresenta il mio occhio, ma mi pone di fronte a qualcosa che trascende il mio campo visivo, ovvero, l’altro buca il mio campo visivo. «Un abisso chiama un altro abisso»[18]. In altre parole, quella trascendenza dell’occhio che vede dall’al di qua del mio campo, ora la vedo come riflessa al di là del mio campo. Il campo è bucato da ambo i lati: alla trascendentalità del mio Io corrisponde la trascendentalità dell’altro Io. O meglio, usando i termini di Wittgenstein: nell’altro vedo il limite del mio mondo. Ma come si può vedere un limite? Esiste una linea che separi ciò che vedo da ciò che non vedo, tra il mio esistere e il mio non esistere? La linea del limite è qualcosa che non vedo ma che in qualche modo si mostra. L’altro soggetto si mostra come la linea dell’orizzonte, che non si vede ma si mostra.
Un limite disegna sempre il mio orizzonte, ma, anche se mi sposto e quindi sposto la linea dell’orizzonte, non posso mai vedere oltre il mio orizzonte, inteso come somma di tutti i miei orizzonti possibili. Il mio orizzonte è un limite intrinseco al mio essere-nel-mondo. Eppure questo limite mi costituisce pur non potendo vederlo. Ho l’impressione che oltre ogni mio orizzonte ci possa essere solo del mostruoso. Ovvero qualcosa che terrifica proprio non mostrandosi. Il radicalmente Altro, che resta sempre al di là…
Si dirà: sappiamo che la funzione soggettiva non è mai solo occhio contemplativo, è qualcosa piena di quel che chiamerei conati. Desideri, intenzionalità, interessi… Al di qua dell’io vedente e dicente c’è un io desiderante (l’io che da Spinoza rimbalza fino a Lacan). Il desiderare non è nel campo, ma trascende il campo stesso come sua condizione di possibilità: esprime il mio voler-vedere o voler-dire. E rende tutto ciò che vedo un qualcosa-che-ho-voluto-vedere (difatti, quante cose ci sono nel nostro campo che non vogliamo proprio vedere!). L’occhio animale, non solo quello umano, è un vedere mosso da pulsioni che ne fanno qualcosa di ben diverso da una contemplazione. E così, nell’occhio dell’altro leggiamo i conati dell’altro. Prima di tutto, il conato di vivere. Insomma, presupponiamo l’essere sia all’io che all’altro io. Ma questo essere si mostra paradossalmente attraverso un buco, uno sprofondamento nel campo oggettivo. È il paradosso essenziale della soggettività: essa si mostra celandosi. La nostra soggettività risuona nell’altro, ma come ciò che nell’altro fa buco. Direi anche che spesso dà buca, quando sentiamo che l’altro è per noi un enigma. Ed è interessante che questa soggettività sia messa in scena, spesso, come imminenza di orrore.
Nel film Psycho di Hitchcock lo spettatore è indotto a pensare che la madre del protagonista Norman sia l’autrice dei due omicidi a cui lo spettatore ha assistito nel corso del film, anche senza averla vista ancora in faccia. Finora lo spettatore l’ha solo intra-vista. Verso la fine, una donna che cerca le vittime giunge finalmente nella casa dove abita la signora assassina, la vede di spalle e poco a poco le si avvicina per parlarle. Lentamente la testa della signora si gira e si scopre che è un teschio imparruccato. La killer era uno scheletro? Questo orrore ci sbatte davanti agli occhi un’intuizione fondamentale: che se vogliamo vedere, conoscere, l’alterità radicale dell’altro, questa ci si mostra, alla fin fine, solo come un teschio con le orbite vuote. Ovvero come un mero contenitore svuotato di soggettività. Come una macchina IA? Se la soggettività è il limite del mondo (visibile e dicibile), andare nella soggettività è entrare nella morte, nel non-esserci. Sono le orbite vuote del teschio il simbolo eccellente della soggettività?
7.
L’occhio dell’altro come messinscena di me soggetto era stato già tematizzato da Platone. In particolare in un dialogo detto minore, Alcibiade I, e che Foucault ha avuto il merito di riscoprire e commentare lungamente[19].
Alcibiade vuole iniziare la sua carriera politica andando all’assemblea per parlare agli Ateniesi, ma Socrate lo trattiene impegnandolo in un dialogo che ha come oggetto, diremmo oggi, la volontà di potenza politica. Quale sapere Alcibiade potrà trasmettere agli Ateniesi? Nessun sapere, conviene Alcibiade pressato da Socrate. Il quale Socrate si definisce amante e tutore di Alcibiade nella misura in cui, precisa, ama l’anima di Alcibiade; e non chiede che in cambio Alcibiade ami la sua [di Socrate] anima. Piuttosto vuole impegnare Alcibiade nel miglioramento della propria anima. Ma, se dobbiamo migliorarla, possiamo conoscere la nostra anima?
Socr. Hai osservato che a guardare qualcuno negli occhi si scorge il volto nell’occhio di chi ci sta di faccia, come in uno specchio, che noi chiamiamo pupilla (kore), perché è quasi un’immagine di colui che la guarda?
Alcib. È vero.
Socr. Dunque, se un occhio guarda un altro occhio e fissa la parte migliore dell’occhio, con la quale anche vede, vedrà se stesso.
Alc. Evidentemente.
[…]
Socr. Se allora un occhio vuol vedere sé stesso, bisogna che fissi un occhio, e quella parte di questo in cui si trova la sua virtù visiva; e non è questa la vista?
Alc. Sì.
Socr. Ora, caro Alcibiade, anche l’anima, se vuole conoscere sé stessa, dovrà fissare un’anima, e soprattutto quel tratto di questa in cui si trova la virtù dell’anima, la sapienza, e fissare altro a cui questa parte sia simile?
Alc. Credo di sì, Socrate.
[…]
Socr. Questa parte dell’anima è simile al divino, e, se la si fissa, si impara a conoscere tutto ciò che vi è di divino – intelletto e pensiero – si ha la possibilità di conoscere sé stessi nel modo migliore.
Socrate dice chiaramente che conoscere sé stessi – cioè la propria anima – è guardarsi in uno specchio, dato che la pupilla dell’altro è il nostro specchio. Insomma, l’Altro è il nostro specchio. Nella terminologia di Lacan, possiamo dire che il soggetto-anima «si sa nel luogo dell’Altro»; ovvero il tutore è… la pupilla. Kore, lo abbiamo visto, significa pupilla e ragazza, rimanda alla figura dell’allieva. Se la pupilla dell’occhio è quella fornita dal maestro-amante perché il pupillo-amato si riconosca, l’anima – pupilla del soggetto – appare nell’Altro, nel tutore. Quindi, conoscere-amare se stessi è amarsi come Altro, chiamato qui “il divino”. Socrate non dice ad Alcibiade «amami!», gli basta dire «ama la tua anima in ciò che ha di migliore», perché sa che dell’anima di Alcibiade lui detiene la chiave. Senza Socrate-specchio, Alcibiade non si conoscerebbe, perché ci si ri-conosce sempre nell’Altro. «Intelletto e pensiero», in Platone, sono quel che oggi chiameremmo soggettività. Oggi connettiamo la soggettività piuttosto al desiderio (il soggetto è chi desidera), dato che nell’intelletto e nel pensiero ci superano di gran lunga le macchine calcolatrici (AI). Ma le AI, come gli ultra-corpi di Don Siegel, non desiderano. Non sono soggette alle tre grandi passioni: amore, odio, ignoranza.
8.
Peter Sloterdijk[20] ha criticato la teoria lacaniana dello stadio dello specchio facendo notare che il possesso di uno specchio, nel quale un bambino di pochi mesi possa guardarsi, era alquanto raro nelle classi popolari solo un secolo fa. Lo specchio era un lusso. Insomma, quell’immagine ideale di sé che, secondo Lacan, ogni bambino si costruisce giocando con lo specchio sarebbe invece la genesi di un “io” squisitamente borghese. Ma, come abbiamo visto, l’obiezione di Sloterdijk può essere radicalizzata: guardarsi nello specchio è una possibilità tecnologica tardiva per Homo sapiens. L’uomo arcaico si specchiava solo nell’acqua cheta e nell’altrui pupilla. Ma forse questo specchiarsi così incerto, confuso e minimizzante era già sufficiente, a un bambino antico, per costruirsi un’immagine ideale di sé, un narcisismo.
Winnicott, commentando il saggio di Lacan sulla fase dello specchio[21], aveva avanzato l’idea che il bambino si auto-idealizza come immagine di sé solo se lui è tenuto da una madre (o da chi per lei) che lo guardi e lo apprezzi. Winnicott insinua insomma che stimiamo noi stessi nella misura in cui l’Altro ci ammira, anche se questa ammirazione è per l’immagine di noi stessi, non per noi stessi. Occorre un incontro di sguardi in cui quello del soggetto e quello dell’Altro si intreccino, fondendosi. Amare sé stessi implica sempre essere amati dall’Altro, simile a quell’altro che ciascuno di noi è per sé stesso.
Ora, il vedere l’altro come mostruoso è ciò che fa fallire l’idillio speculare descritto da Winnicott. Immaginiamo una scena: nostra madre ci tiene in braccio davanti a uno specchio e sorride compiaciuta alla nostra immagine – oppure, senza specchio guarda radiosa la nostra faccia e noi ci vediamo ammirati e amati nei suoi occhi. Ma poi, d’un tratto, il suo volto si oscura, il suo sorriso si spegne, il suo sguardo emana sconcerto… “Che cosa ha visto in me che non va?” ci chiediamo. Il suo sguardo ora ci allarma, non capiamo che cosa di noi la turbi. Viene in mente l’attimo in cui i personaggi del film Bird box scorgono l’Altro invisibile: non appaiono spaventati, anzi, abbozzano uno sguardo di inerme dolcezza, che si spegne però subito nel passaggio all’atto suicidario… Vedere la Cosa implica, come in una conseguenza logica, la sparizione del soggetto che La vede. O l’Altro, o me. Quindi, quando lo sguardo della (mitica) madre si rabbuia, sento – anche se non so – che lei ha visto come un buco abissale in me. Ha smascherato il buco che contengo, un vuoto che contagia il mio volto tutto come mostruoso.
È compito della psicoanalisi – o della filosofia, o della letteratura… – dire finalmente questo buco che spezza la nostra infatuazione di noi stessi? È possibile rivelare finalmente il significante mancante? Nei termini della parabola di Wittgenstein: l’occhio fuori del campo visivo che si scorge nel campo stesso finalmente vede sé stesso? O vede solo l’immagine alienata, mondanizzata di sé? Nell’epimeleia heautou[22], in quella cura di sé che costituiva l’ideale dell’uomo greco libero e colto, era chiaro a quest’uomo cosa fosse questo heautou? Era l’anima, la psyché? Ma per i Greci l’anima era tutto ciò che nel mondo non è mosso da altro e si muove da sé. Aver cura di sé era aver cura di un semovente? Non a caso Socrate dice ad Alcibiade: «devi amare il divino in te». Ma che cosa è il divino, se non è più per noi intelletto e pensiero? E cosa è per un filosofo che sarà condannato a morte proprio perché aveva introdotto nella Città un divino troppo altro, un inconcepibile daimon?
No, non è compito dei discorsi (filosofico, psicoanalitico, letterario…) dire il buco della soggettività. Perché questo non si può dire. Anche se continuamente si mostra nel nostro guardarci l’un l’altro e nel nostro parlare l’uno con l’altro. Il singolo si esprime sempre, ma non può dire nulla di sé.
Ora, parlare di divino è sempre parlare di ciò di cui non si può dire nulla. Si pensi a quel che Lévi-Strauss ha detto della nozione polinesiana di mana[23] e di concetti analoghi in altre culture. Il mana è descritto come una potenza, una forza, con significazioni tra loro contraddittorie. E Lévi-Strauss ci fa notare che mana significa… ciò che non ha nome. È un simbolo allo stato puro, con valore simbolico zero. (Il passaggio dai politeismi al monoteismo è il passaggio da un divino che ha tanti nomi a un divino senza nome. I monoteismi sono l’anonimato divino.) Mana, che noi chiamiamo divino, è il significante dell’assenza di significante. È un modo di dire l’indicibile, come quando in italiano diciamo “quel coso” o “quell’aggeggio” per indicare qualcosa di cui ci sfugge il nome. C’è una potenza divina – e per altri versi anche diabolica, comunque sovrannaturale – nell’Innominato. La sua potenza, fasta o nefasta, è legata proprio al suo non poter aver nome. Allora, a meno di non essere credenti e quindi di trovare pace nel culto del Coso, cosa possiamo dire della potenza di questo Coso, di qualcosa che non solo non possiamo dire, ma che non possiamo nemmeno vedere, dato che è come una frattura, una breccia nello sguardo?
Forse quel qualcosa che troviamo nelle varie culture, e che nella nostra chiamiamo “sacro” o “divino”, è proprio il tentativo disperato di dire qualcosa che il linguaggio stesso espunge dal dicibile. Il linguaggio sembra consistere in questa riserva di indicibile. Ma se non avesse questa riserva di indicibile, sarebbe solo del blablabla.
Dare un nome a questo Coso sarebbe mascherarlo di nuovo, velarlo, dargli un’immagine che ne celi l’essere. (Il cristianesimo Gli ha dato nome Gesù, ma così è entrato in una sorta di auto-contraddizione.) Del resto, questo Coso ha essere? Ha essere il mostruoso, ovvero ciò che proprio non mostrandosi si mostra? Credo che la lunga mistificazione della metafisica sia stata di pretendere di rivelare quel che la religione velava, ovvero dirci il nome del Coso. Non possiamo né dobbiamo trovare il vero nome del Coso, possiamo però indicarne il luogo. Il luogo logico, non spaziale.
Questo luogo, pensiamo, è connesso alla primaria alienazione dell’essere umano nel linguaggio (è la strada presa da Lacan). È grazie al linguaggio che possiamo esprimerci, ma grazie a un’alienazione originaria nell’Altro, nel linguaggio che ci viene dagli altri (è quel che Freud tematizzava[24], probabilmente, quando parlava di Urverdrängung, rimozione originaria). Simmetricamente, il caos del mondo viene in parte imbrigliato, domato dai nomi che diamo a cose e concetti. Ma questa operazione di nominazione del mondo lascia cadere qualche cosa di noi stessi e del reale che vivrà una sorta di vita sotterranea, che si anniderà come una bestia che in noi giace ma non svanisce, il Coso, il mana, che ha la forza distruttiva di ciò che non è stato aggiogato dal linguaggio e dal senso. Eppure molti di noi ne avvertono la presenza che cova, e che emerge d’un tratto in certi momenti, producendo un effetto unheimlich, perturbante, in noi. Porterò un esempio autobiografico.
Verso i sei anni scoprirono la mia ipermetropia e altri per me incomprensibili “difetti” visivi (l’ambliopia) che comportarono un paio di orribili occhiali che a lungo mi rifiutavo di indossare in pubblico, per paura di essere deriso. Fu più o meno in questo periodo che, leggendo un giornale con foto con un cugino, questi indicò “quel signore con le lenti”. In effetti era la prima volta che sentivo la parola “lenti”, per me erano occhiali, per cui ebbi un attimo di perplessità che si tramutò in un sentimento perturbante… Anche se capii presto che ‘lenti’ e ‘occhiali’ erano sinonimi, percepii un alone misterioso attorno a quella foto, un enigma che era a sua volta enigmatico. “Le lenti” per un po’ furono il mana. Ora, col senno di poi, capisco che si giocava allora un mio cambiamento profondo di status estetico-sociale: da bambino “normale” diventavo un quattrocchi, come si diceva allora in modo beffardo, ovvero, cambiavo posizione nel mondo. E questo cambio di posizione mi rendeva mostruoso ai miei stessi occhi, occhi che si spegnevano come tali – e difatti dopo per un periodo temetti seriamente di diventare cieco.
Qui cogliamo la strana logica dell’inconscio: proprio quelle lenti che mi permettevano di vedere meglio erano il segno della mia cecità. La cecità era allora il modo temuto di non-esserci, non-vedere come non-esserci, e quindi rimandava a un me fondamentale che il linguaggio travestiva e annullava nella parvenza delle parole, un mio Urselbst, che provvisoriamente venne significato dal nuovo termine “lenti”. “Lenti” era insomma il segno del mistero della cecità, del non-esserci di qualcosa che pur c’è, del soggetto vivente e parlante in quanto “io”, ma questo io non è cosa del mondo… Questo perturba: che un non-mondo emerga nel mondo. Che il campo visivo nella metafora di Wittgenstein (il mondo come dicibile, riconoscibile) sia bucato da qualcosa di abissale, che è nel visibile-dicibile come macula, strappo inguardabile, come una gelatina informe che cancella la rassicurante architettura del mondo, quel mondo così ripetitivo, domestico, noioso…
9.
Quindi, il mostruoso è in un certo senso l’evento puro, in quanto tale senza nome. Una cosa è la zoologia fantastica di cui Borges fece il manuale, altra cosa è il mostro che sfida ogni categorizzazione, in quanto è assolutamente singolare. Se il mostruoso è il reale che si mostra, esso dice la singolarità che in quanto tale non si lascia catturare in un significante. E la prima singolarità con cui abbiamo a che fare è la nostra: siamo esseri senza nome e senza descrizione. L’inscriverci comporta anzi una vergogna, ci sentiamo degli infiltrati nel mondo – e non a caso oggi si parla molto di sindrome dell’impostore, ovvero di persone che hanno la sensazione di vivere la vita sociale come impostura. Mi chiedo se questa impostura non consista nella nostra inscrizione originaria nel mondo sensato, che è sempre il mondo dell’Altro. E la vergogna (aidos per i Greci: rispetto) è il mettere a nudo la nostra estraneità al mondo, il denunciarci come “altro da quel che si appare”, solo che questa distanza dalla nostra immagine sociale non è a sua volta dicibile, non è qualcosa che si può confidare. La nostra singolarità è la colpa che non si redime nella confessione.
E se colleghiamo il mostruoso per lo più alla morte, è perché il vero mostruoso che non possiamo guardare in faccia è la morte, puro evento senza senso. Eppure sappiamo che solo la morte può dare senso alla vita. Solo il fatto che la vita abbia un limite le dà senso. E infatti Borges ci descrive la vita più insensata, quella degli immortali[25]. Una vita in cui qualsiasi cosa può accadere non è vita. L’unica cosa che dia senso alla vita degli immortali è trovare un fiume che tolga loro la maledizione dell’immortalità. Eppure solo l’evento più senza senso di tutti – la morte – è la condizione del senso. Perché la morte ci singolarizza, e la singolarità di ciascuno di noi è ciò che mai potrà essere visto o detto.
Pubblicato su “Il pensiero. Rivista di filosofia”,
anno 2024, vol. LXIII, fascicolo 1, pp. 23-38 ISBN 978-88-5529-492.
NOTE
[1] S. Freud, L’Uomo dei lupi, trad. it. di M. Marcacci, Feltrinelli, Milano 1994.
[2] S. Freud, “Il perturbante”, Opere di Sigmund Freud, 9, Bollati Boringhieri, Torino 2000.
[3] Conservato a Palermo, in Palazzo Abatellis.
[4] In Much Museum, Oslo, Norvegia.
[5] Paolo di Tarso, «Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia.» (1 Corinzi 13, 12. Edizione C.E.I.)
[6] C. Tagliavini, Di alcune denominazioni della pupilla, Typ. del Senato, 1949.
[7] J. Lacan, Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, in Ecrits 1, Seuil, Paris 1999, pp. 92-99.
[8] J.P. Sartre, La trascendenza dell’ego, a cura di R. Ronchi, Marinotti, Milano 2011. J.P. Sartre, L’Etre et le néant, Gallimard, Paris 1943.
[9] Ovviamente, posso conoscermi attraverso lo specchio, una foto, un video… Ma sono le immagini mondane del mio volto, non il mio volto. Ovvero, mi vedo come gli altri mi vedono, non come io dovrei vedermi…
[10] Il romanzo è stato portato più volte sullo schermo, in particolare da Andrei Tarkovskij nel 1972.
[11] Film diretto nel 1956 da Don Siegel. Ha avuto vari remakes.
[12] Ho affrontato questi temi in: Macchine celibi, in «aut aut», 388, 2020, pp. 179-195.
[13] Bird Box di S. Bier (2018); Bird Box Barcelona di D. e A. Pastor (2023).
[14] R. Ronchi, Prima persona, «err. scritture dell’imprevisto», 2, drop 12, 2023.
[15] Potremmo dire che, rispetto a un occhio immobile, il campo visivo è una semi-sfera in cui l’occhio occupa il centro del diametro. Sempre quindi di un centro si tratta.
[16] Vedi S. Benvenuto, Il setaccio di Wittgenstein. Wittgenstein e l’etica in “L’altro Wittgenstein”, numero speciale a cura di S. Benvenuto e G. Leghissa, «aut aut», 394, giugno 2022, pp. 36-48.
[17] È il modo in cui Sartre definiva il “per-sé”, la coscienza. J.P. Sartre, op. cit..
[18] Salmi 42, 7.
[19] In M. Foucault, L’ermenutica del soggetto. Lezioni al Collège de France, 1981-1982, Si veda anche: S. Benvenuto, Lo specchio della potenza. Eros e volontà di potenza in Platone [Alcibiade I], «Il Cannocchiale. Rivista di studi filosofici», n. 2, maggio-agosto 2002, pp. 3-27.
[20] P. Sloterdijk, Sfere I. Bolle, a cura di G. Bonaiuti, Meltemi, Roma 2009. Cfr. A. Lucci, Lo stadio dello schermo come formatore della funzione del noi. Linee per un’antropologia mediale a partire da Peter Sloterdijk e Thomas Macho, Albalibri, Livorno 2011.
[21] D.W. Winnicott, “Mirror-role of Mother and Family in Child Development”, Playing and Reality, Tavistock Publications, London 1971, pp. 111-118.
[22] È il tema reso popolare da M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit.
[23] C. Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, Humensis, Paris 2012.
[24] S. Freud, “La rimozione”, 1915, Opere Complete di Sigmund Freud, vol. 9, pp. 5-14, Bollati-Boringhieri, Torino.
[25] J.L. Borges, “L’immortale”, L’Aleph, traduzione di F. Tentori Montalto, Milano, Feltrinelli 1959